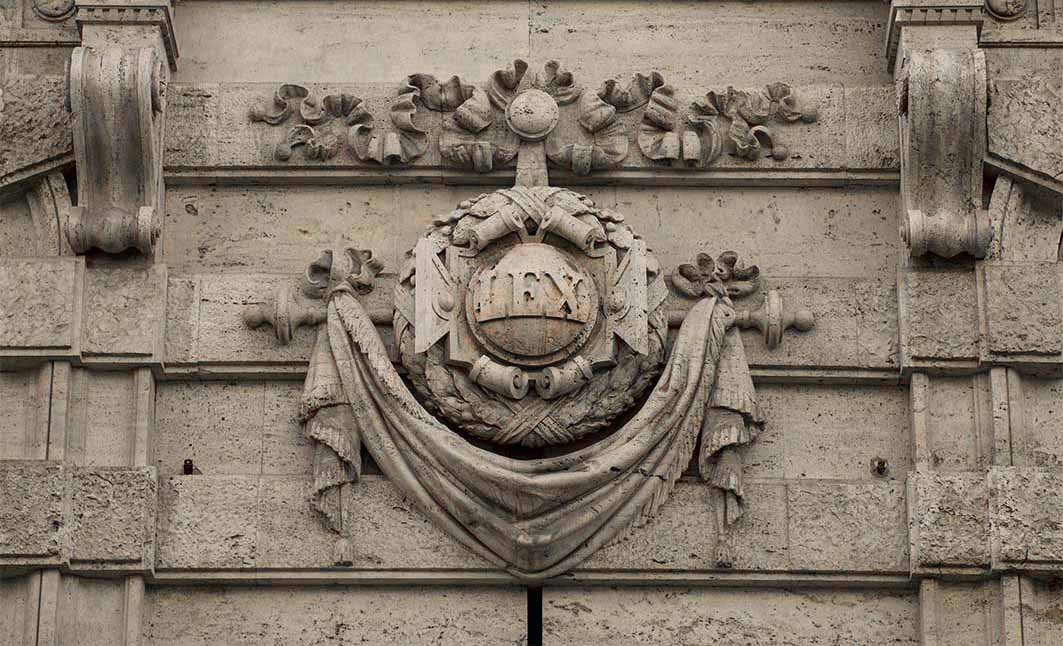CORTE DI CASSAZIONE – Sez. III – 6 maggio 1998, n° 4578 – Pres. Grossi – Est. Talevi – P.M. Maccarone (concl. conf.) – Avanzi (Avv. Pottino) c. Banco di Chiavari e della Riviera Ligure (Avv.ti Ciccotti e Cella).
(Conferma App. Genova 18 – 30 gennaio 1996).
Pubblicato su Giustizia Civile – Anno XLIX Fasc. 4 – 1999
[7332] Revocatoria (azione) – Condizioni e presupposti – Patrimonio del debitore – Variazione qualitativa – Eventus damni – Configurabilità – Onere probatorio – Ripartizione
(Cod. civ., art. 2901, 2697)
In materia di azione revocatoria, l’eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni) ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili). Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragione del creditore (1).
(1 ) [7332] Eventus damni ed onere della prova nella revocatoria ordinaria, tra il principio della garanzia patrimoniale e la libertà di iniziativa economica del debitore.
- La sentenza che si annota, nell’affrontare la tematica dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria, con particolare riferimento al «pregiudizio» alle ragioni creditizie di cui all’art. 2901 1° comma c.c., effettua altresì alcune rilevanti puntualizzazioni – ignote alla giurisprudenza precedente, anche se coerenti con le sue affermazioni – in ordine ai limiti dell’onere probatorio incombente sul creditore revocante.
Nella pronuncia in commento la Suprema Corte conferma la correttezza, in termini giuridici e logico–formali, della precedente statuizione della Corte d’Appello di Genova, nella quale si era asserito che, ai fini della configurazione del c.d. eventus damni, non sia necessario che il patrimonio del debitore abbia subito una cospicua diminuzione (di tipo quantitativo) ma si riveli, al contrario, sufficiente una sua mera alterazione di carattere qualitativo.
Il Supremo Collegio ha motivato, sul punto, osservando, che «secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, per la sussistenza del pregiudizio non è necessario un danno effettivo, ma è sufficiente un pericolo di danno, derivante ad esempio da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da maggiore incertezza o difficoltà nell’esazione coattiva del credito; in particolare va rilevato che non è necessaria la sussistenza di una diminuzione quantitativa dei beni (il cui valore oggettivo può restare anche immutato) ma è sufficiente che si produca un mutamento qualitativo il quale comporti ad esempio una maggiore occultabilità dei medesimi come nel caso di sostituzione di beni immobili con beni mobili».
Tale passaggio logico della motivazione si rivela essenziale per intraprendere un esame della materia de qua, in quanto evidenzia i due diversi angoli visuali che (per quanto strettamente interrelati) possono essere all’uopo adottati.
Da un lato, si pone un problema di carattere pratico, relativo ai criteri in concreto utilizzabili ai fini della decisione circa la revocabilità o meno di atti dispositivi pretesi pregiudizievoli dal creditore. Dall’altro lato, emerge il problema della qualificazione del «pregiudizio» di cui all’art. 2901, 1° comma c.c. nei termini di danno attuale e concreto o piuttosto in quelli di pericolo di danno (futuro ed eventuale).
La sentenza in commento, salva la puntualizzazione effettuata in tema di distribuzione dell’onere della prova tra le parti, si ricollega pressoché in toto alle posizioni espresse in ordine ai due aspetti da una consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito ([1]) nonché dalla dottrina predominante ([2]).
La Suprema Corte, infatti, asserisce, relativamente al primo profilo, la revocabilità non solo di quegli atti che abbiano diminuito il patrimonio del debitore al di sotto della soglia della piena capienza, ma anche di quelli che ne abbiano alterato le componenti al punto da ingenerare il rischio che il creditore debba intraprendere un’esecuzione forzata più incerta o difficoltosa.
Si tratta, nella specie, di analizzare quali siano nella giurisprudenza costante, a cui la sentenza in commento si ispira, i criteri utilizzati per giungere alla conclusione della revocabilità, nel concreto, di un atto specificamente impugnato.
Un Autore ha, di recente, operato una sintesi delle posizioni espresse con grande costanza dalla nostra giurisprudenza, evidenziando come la revocabilità di un atto dispositivo discenda dal verificarsi di tre possibili situazioni ([3]):
a) violazione del criterio quantitativo della sufficienza e capienza del patrimonio del debitore (credito pari a 50 e patrimonio pari a 75: l’atto sarebbe revocabile ove determinasse una diminuzione patrimoniale superiore a 25);
b) violazione di un primo criterio qualitativo, posta in essere con la sostituzione di beni facilmente perseguibili ed aggredibili con altri facilmente distraibili e/o occultabili e/o deteriorabili, con l’effetto di una maggiore incertezza sul buon esito della sempre eventuale esecuzione (l’atto impugnato ha modificato la composizione del patrimonio, sostituendo ad un immobile del denaro);
c) violazione di un secondo criterio qualitativo, perpetrata con la sostituzione di beni facilmente aggredibili con altri comportanti una dispendiosa o giuridicamente difficoltosa esecuzione forzata (sostituzione di un immobile collocato in Italia o avente un indiscutibile valore di mercato con altro situato all’estero o difficilmente alienabile in sede di vendita all’incanto).
Emerge da tale prima ricognizione come il termine «pregiudizio» venga ravvisato, in concreto, in una varietà notevole di situazioni e come esso non dipenda esclusivamente da una riduzione del patrimonio al di sotto della soglia della capienza ma anche dal fatto che quest’ultimo sia costituito da beni che per la loro natura, quindi qualitativamente, non si prestano ad offrire particolari garanzie al creditore.
In ogni caso si può ritenere pacifica la revocabilità di un atto che diminuisca il patrimonio del debitore al di sotto della soglia della capienza. In tale evenienza, il pregiudizio per il creditore – anche se valutato ora per allora (ossia in prospettiva di un’eventuale esecuzione forzata) – si rivela talmente lapalissiano da determinare senz’altro la revocabilità dell’atto impugnato ([1]). La stessa Suprema Corte sembra considerare tale eventualità in maniera particolare: dal passaggio della motivazione riportato sembra intuirsi che, secondo la S. C., si possa ravvisare un’ipotesi di vero e proprio danno attuale nel caso di diminuzione patrimoniale, dovendosi ricondurre, al contrario, il caso dell’alterazione patrimoniale all’ipotesi del periculum damni. Sulla correttezza in termini teorici di una simile impostazione si avrà modo di ritornare più avanti.
Semmai l’interrogativo che ci si può porre, ove si ragioni in termini puramente quantitativi, è quello contrario, ossia se un atto dispositivo di un bene che abbia comportato una rilevante riduzione del patrimonio, seppur entro i limiti della capienza, possa o meno essere revocato. La legittimità dell’interrogativo risiede nel fatto che in nessuna norma è stabilito nella capienza la soglia al di sotto della quale scatti la revocabilità dell’atto impugnato.
La stessa sentenza in commento, ricalcando le considerazioni già precedentemente operate dalla Corte d’Appello, ha evidenziato l’inesistenza di tale limite, sottolineando come, per un verso, sia assai frequente che il valore del patrimonio sia, già al sorgere dell’obbligazione, inferiore a quello del credito e, per un altro verso, come a fronte del termine usato dal legislatore – il «pregiudizio» alle ragioni del creditore – non abbia fondamento normativo ricollegare l’accoglibilità della revocatoria alla diminuzione del patrimonio al di sotto del valore del credito.
D’altronde dichiarare la revocabilità di un singolo atto che abbia determinato la riduzione del patrimonio (inizialmente esiguo) di poco al di sotto della soglia della capienza, e non revocare,
d’altro canto, una serie di atti dispositivi che abbia assottigliato un ingente patrimonio fino a renderlo appena superiore ad essa, sembra conclusione troppo severa per essere accolta e per non ingenerare perplessità.
Già da tale banale esempio si evince come l’ancorarsi ad un metro di valutazione di carattere esclusivamente quantitativo possa comportare delle conseguenze penalizzanti o comunque inique nei singoli casi di specie; nel contempo si intuisce quale importante apporto possa essere fornito, oltre che dalla considerazione delle circostanze del caso concreto connotanti l’atto dispositivo, anche dalle situazioni di carattere soggettivo afferenti il debitore ed il terzo acquirente.
Per il momento, si deve rilevare il fatto che la sentenza che dichiari parzialmente inefficace, ex art. 2901 c.c., un atto che abbia comportato una riduzione del patrimonio del debitore al di sotto del valore del credito (sempre nell’ipotesi ovviamente in cui il primo fosse superiore, al momento della nascita dell’obbligazione, al valore del secondo) non possa certamente destare stupore, proprio tenuto conto del dettato normativo (il termine in esame è di tale ampiezza da comprendere senz’altro le situazioni più lesive per il creditore) nonché del fatto che l’incapienza del patrimonio ad altro non corrisponde, in potenza, se non all’insolvenza assoluta del debitore ([1]).
Senz’altro meritevole di una maggiore attenzione è, però, l’insieme dei casi in cui il pregiudizio per le ragioni creditizie venga indotto dall’applicazione dei due criteri di carattere c.d. qualitativo, ossia quando si ravvisi un pericolo di danno nella sostituzione di beni immobili con beni mobili – tra cui in particolare il denaro ([2]) – e/o con beni deteriorabili o facilmente occultabili e/o con altri (al limite immobili) tali da incrementare la difficoltà o l’incertezza dell’esecuzione forzata.
Stante il costante ricorso della giurisprudenza a tali criteri, si pone essenzialmente un problema di metodo, consistente nel verificare se ed in che modo essi debbano venire in gioco nell’apprezzamento della pericolosità di un atto per il creditore e del pregiudizio con esso arrecatogli. Il problema consiste nel verificare se i criteri qualitativi vadano impiegati autonomamente rispetto al criterio della sufficienza quantitativa o in stretta connessione con questo, e se sia corretto, conseguentemente, addivenire alla declaratoria di inefficacia di un atto sulla semplice scorta di un richiamo ai primi.
La sentenza in commento, pur asserendo la necessità del loro impiego nella valutazione del patrimonio, non fornisce particolari indicazioni sulle relazioni intercorrenti tra i medesimi ed il criterio quantitativo: non è chiaro, cioè, se basti la semplice sostituzione del bene immobile con il bene mobile per determinare la situazione di «pregiudizio» o se, invece, tale alterazione, per essere rilevante ex art. 2901 c.c., debba in qualche modo riverberarsi sul patrimonio in termini quantitativi, conducendo il giudicante a rideterminare il valore di esso.
Sembrerebbe in verità che, secondo la Suprema Corte, l’atto dispositivo vada revocato laddove abbia semplicemente comportato la fuoriuscita dal patrimonio di un bene immobile con l’ingresso di un bene mobile deteriorabile o estremamente occultabile (come nel classico caso della sostituzione dell’appartamento con il corrispondente denaro o prezzo di mercato). In altri termini, irrilevante si rivelerebbe la circostanza che il valore contabile del patrimonio residuo sia immutato. In tal caso, dunque, il criterio di apprezzamento qualitativo verrebbe utilizzato da solo, senza alcun collegamento a quello quantitativo della sufficienza e della capienza patrimoniale.
Che tale sia la posizione espressa dalla Suprema Corte sembra essere confermato dall’esplicito richiamo, contenuto nella sentenza, ad alcuni passaggi della impugnata decisione della Corte d’Appello, ove si asseriva, tra l’altro, che «sul piano teorico non rileva che il credito possa essere soddisfatto nonostante gli atti di disposizione».
Appare chiaro che, in tale prospettiva, il pregiudizio si verifichi con la semplice uscita di un immobile dal patrimonio del debitore, non importando il fatto che il valore di esso possa essere incrementato: è ben possibile che il debitore abbia alienato il bene ad ottime condizioni economiche – anche superiori a quelle correnti di mercato – dovendosi senz’altro riconoscere un incremento della sua garanzia patrimoniale in termini economico–contabili. Tale circostanza rimane comunque irrilevante, specie ove la pericolosità di un atto dispositivo venga indotta sulla scorta dei criteri qualitativi.
L’applicazione dei criteri di valutazione qualitativi così effettuata – in virtù della quale gli stessi avrebbero un ruolo autonomo in sede di apprezzamento del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore da un singolo atto dispositivo – non esclude la possibilità, che è peraltro largamente ed esplicitamente riconosciuta, di un loro impiego congiunto a quello del criterio c.d. quantitativo.
Tale caso potrebbe verificarsi ove un bene fosse stato “svenduto” ad un prezzo inferiore a quello corrente di mercato, ingenerando da un alto una ingente diminuzione del patrimonio e dall’altro lato un’alterazione delle sue componenti : l’atto dunque sarebbe doppiamente revocabile, in primo luogo in quanto produttivo di una notevole riduzione della garanzia patrimoniale (si è visto sopra che anche l’atto che non abbia ingenerato l’incapienza del patrimonio sarebbe revocabile) ed in secondo luogo in quanto comportante l’immissione nel capitale del debitore di una quantità di denaro, senz’altro meno atta a garantire le ragioni creditizie.
Se ne deduce che la giurisprudenza, lungi dall’affrontare la questione dell’applicazione dei criteri citati quale problema di metodo, opera per lo più – e a ben guardare correttamente – appuntando l’attenzione sul profilo sostanziale : in tale prospettiva, essa addiviene ad un’applicazione dei criteri menzionati sia congiunta che autonoma, a seconda dei casi concreti portati alla sua cognizione.
In dottrina, però, non manca chi evidenzia come, sul piano del metodo, i criteri qualitativi dovrebbero essere utilizzati in stretta connessione (e giammai autonomamente) con il diverso criterio di valutazione di tipo quantitativo e, soprattutto, in maniera preventiva, al solo fine di addivenire alla determinazione di un valore del patrimonio differente da quello strettamente economico, derivante dalla considerazione del complesso dei beni mobili ed immobili compresi nel capitale del debitore ([1]).
In altre parole, l’ingresso dei criteri qualitativi nell’apprezzamento del patrimonio del debitore avrebbe un senso solo in quanto possa condurre a determinare – alla stregua di alcune valutazioni tendenti a discriminare alcuni beni rispetto ad altri (in relazione alla maggiore o minore garanzia da essi offerta al creditore) – un valore contabile ed economico del patrimonio diverso da quello effettivo.
In tal modo si renderebbe necessario predeterminare, in nome della possibilità di effettuare sempre e comunque una valutazione di tipo quantitativo, una sorta di scala di apprezzamento dei beni, funzionale alla valutazione da operare ex art. 2901 c.c. e direttamente proporzionale alla loro capacità di fornire idonee garanzie ai creditori.
La determinazione del valore del patrimonio, ai fini della stessa configurabilità del «pregiudizio», andrebbe operata – ove siano presenti beni diversi da quelli immobili – attraverso i criteri qualitativi; solo successivamente, ossia per decidere la revocabilità dell’atto impugnato, si provvederebbe al classico confronto tra il valore del credito e quello del patrimonio determinato alla stregua della valutazione di cui sopra. In altri termini secondo tale impostazione l’atto sarebbe revocabile solo in quanto abbia comportato la riduzione del patrimonio – valutato secondo i criteri quantitativi o qualitativi – al di sotto del valore del credito ([2]).
In tale ottica si porrebbe l’esigenza di attribuire al denaro un valore inferiore rispetto a quello proprio dei beni immobili, con il rischio di dar vita a dei risultati del tutto arbitrari sul piano operativo. Il denaro, a giudicare dalle posizioni espresse dalla giurisprudenza e dalla stessa sentenza in commento sembrerebbe non avere alcun valore (quale che ne sia l’ammontare all’interno del patrimonio del debitore), con la conseguenza che, alienato un appartamento in cambio della corrispondente somma di denaro, si produrrebbe la conseguenza della revocabilità ipso facto dell’atto di disposizione ([3]).
Tali osservazioni critiche non hanno l’intento di revocare in dubbio la circostanza che il denaro sia bene estremamente occultabile e che esso non possa certamente rappresentare una garanzia considerevole delle ragioni creditizie. Né si vuole negare che, in un’ottica volta a porre in discussione la capacità del denaro di offrire garanzia al creditore, sia rilevante il fatto che un appartamento venga venduto a poco prezzo oppure ad un prezzo superiore a quello di mercato, in quanto del tutto indifferente diviene il valore assunto dal patrimonio ove esso venga ad essere composto dal bene fungibile per antonomasia: così come sono occultabili cento milioni lo sono trecento milioni.
Il problema piuttosto è quello di evitare risultati eccessivamente arbitrari : stante la mancanza di riferimenti normativi che permettano tra l’altro di operare una discriminazione tra i vari tipi di beni, sarebbe difficile individuare la base logica sulla quale giungere ad attribuire al denaro ad esempio un valore contabile pari a zero piuttosto che quello di ¼ dell’intero ammontare volta a volta considerato. La stessa revocabilità di un atto dipenderebbe dal fatto che il singolo Giudice conferisca, in assenza di indicazioni normative, ad un patrimonio liquido pari a 100 un valore contabile di 0 o di 25.
È preferibile dunque ritenere revocabile un atto in virtù della semplice considerazione della sua pericolosità, insita nelle stesse caratteristiche del bene entrato a far parte del patrimonio, nell’entità della dismissione operata e nelle altre circostanze che (ove ve ne siano) connotino in concreto il singolo atto impugnato, piuttosto che tentare di attribuire a tutti i costi un valore ad un bene sulla base di un apprezzamento assolutamente astratto.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, appare riduttivo ritenere che l’apprezzamento circa l’esistenza del pregiudizio sia questione di carattere puramente quantitativo, stante in particolare l’assenza di appigli normativi legittimanti un simile approccio.
Sembra, dunque, che la dottrina in esame addivenga alle conclusioni avversate, spinta dalla preoccupazione di evitare il perpetuarsi di orientamenti giurisprudenziali eccessivamente restrittivi per il debitore.
La valenza fondamentale da attribuire ad essa va rinvenuta, quindi, non tanto nelle posizioni dogmatiche espresse dalla medesima, a ben guardare poco condivisibili, quanto nello stimolo a rivedere alcune posizioni assunte dalla nostra giurisprudenza predominante, specie ove, non proprio a torto, considera i beni immobili quelli che offrono la massima garanzia al creditore. Tale dottrina sembra voler sottolineare la circostanza che anche altri beni (basti pensare alla nozione introdotta non da molto nel nostro ordinamento di valore mobiliare) andrebbero attentamente valutati nella loro potenzialità di garanti del debito.
Tale problema, com’è chiaro, non può essere risolto come problema di metodo, bensì come un problema sostanziale, da incentrarsi sull’esatto apprezzamento dell’importanza di certe forme di investimento all’interno della nostra società e della rilevante diffusione che tali beni o valori hanno ormai tra il pubblico dei risparmiatori.
Se così è, si deve concludere che le posizioni espresse dalla giurisprudenza si rivelano anacronistiche sotto tale profilo sostanziale e non certo sotto quello del metodo di utilizzazione dei criteri di valutazione dianzi considerati. La stessa giurisprudenza, non sempre al passo con l’evolversi dei tempi, dovrebbe a tal riguardo manifestare maggiori sensibilità ed apertura nei confronti delle nuove forme dell’agire economico, abbandonando quell’atteggiamento di radicale disconoscimento delle formule d’investimento oggi in voga presso i piccoli risparmiatori. D’altronde tale atteggiamento dovrebbe essere assunto dai nostri giudici, specie in quanto nel nostro paese l’imposizione sugli immobili è notoriamente abbastanza elevata e scoraggia i risparmiatori ad investimenti sul mercato immobiliare piuttosto che su quello dei titoli o valori mobiliari. Ciò comporta com’è intuibile la conseguenza che, in numerosissimi casi, i Giudici si trovano a valutare patrimoni costituiti per lo più da investimenti di tipo mobiliare piuttosto che immobiliare.
Alla stessa revisione dovrebbe essere assoggettato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche gli atti dispositivi che accentuino i costi di un’esecuzione forzata o che ne accrescano la difficoltà giuridica sarebbero revocabili. A tal riguardo, un interrogativo si pone in via preliminare e prioritaria: è legittima l’interpretazione del termine «pregiudizio» a tal punto estensiva da ricomprendere anche la maggiore difficoltà in termini giuridici dell’esecuzione forzata o la sua maggiore onerosità in termini economici?
A ben guardare l’individuazione di una risposta definitiva all’interrogativo citato non è auspicabile, dal momento che solo l’analisi dei casi specifici può portare alla soluzione di volta in volta equa in concreto.
Appare certo che solo un apprezzamento effettuato caso per caso delle situazioni dedotte in giudizio possa determinare delle risposte idonee: certamente non si può limitare la libertà di scelta propria del debitore, solo in nome del diritto del creditore ad un’esecuzione agevole.
Si nota, al riguardo e del tutto incidentalmente, che appare assai pericoloso un atteggiamento troppo incline a sanzionare le iniziative del debitore in virtù di un non meglio precisato diritto del creditore alla agevolezza della procedura esecutiva. Una mortificazione inutile delle esigenze e della libertà del debitore come homo oeconomicus non può che produrre delle conseguenze negative a livello di traffici giuridici, penalizzando la stessa mobilità del capitale che è alla base di una libera economia di mercato.
Se ne trae, quindi, la conferma che delle risposte definitive non possano essere reperite ed anzi debbano essere trovate piuttosto per mezzo di una valutazione non tanto ed esclusivamente rivolta all’aspetto oggettivo della lesione della garanzia ingenerata dall’atto dispositivo, quanto tramite un apprezzamento soggettivo del comportamento del debitore e del terzo acquirente: d’altronde il processo di “oggettivazione” a cui l’azione revocatoria è stata assoggettata, nel corso dell’ultimo secolo, non può aver comportato una eliminazione totale dell’aspetto soggettivo, dapprima predominante, se è vero (com’è vero) che l’art. 2901 c.c. ancora prevede l’esame dello stato soggettivo del debitore e del terzo acquirente. - La dottrina avversata non appare affrontare la questione dei limiti dell’onere probatorio, lasciando quasi intuire che incomba sul creditore l’onere di dimostrare non solo la pericolosità dell’atto dispositivo, ma anche l’insufficienza del patrimonio residuo rispetto al valore del credito ([1]).
La Suprema Corte, al contrario, disegna, anche sul versante processuale, un quadro particolarmente coerente, dal quale si evince oltre ad una comprensibile ripartizione dell’onere probatorio tra creditore e debitore anche una netta indicazione del ruolo proprio del Giudice chiamato ad apprezzare il «pregiudizio» derivante da un determinato atto dispositivo ([2]).
E’ bene rilevare che la soluzione di tale problematica finisce per risentire delle diverse posizioni espresse in tema di pregiudizio e della diversa utilizzazione che si prospetti dei su menzionati criteri di valutazione del patrimonio del debitore.
Laddove ad esempio si ritenga, a nostro parere preferibilmente, che l’eventus damni sia integrato anche nel caso in cui il patrimonio abbia subito una profonda modificazione in termini qualitativi, non avrebbe alcun senso imporre al creditore revocante l’onere di provare che il patrimonio residuo sia (eventualmente) diminuito al di sotto del valore del credito, stante il fatto che in tale prospettiva l’atto impugnato sarebbe dichiarabile inefficace a prescindere da tale circostanza (e dalla dimostrazione ad essa relativa).
Nella prospettiva opposta, secondo cui la valutazione della pericolosità dell’atto per il creditore si riduce sempre ad un apprezzamento quantitativo, il revocante sarebbe sempre chiamato in base alle norme di cui all’art. 2697 ss. c.c. a dimostrare che il patrimonio residuo del debitore sia incapiente, in quanto inferiore al valore del proprio credito.
Anche per tale via, dunque, si traggono delle conferme indirette circa la maggiore correttezza delle posizioni espresse da parte della giurisprudenza, specie ove si consideri che se è ragionevole chiedere al creditore di dimostrare la pericolosità di una dismissione alla luce della sua oggettiva entità, dei soggetti tra cui l’atto è stato posto in essere nonché delle ulteriori circostanze concrete, non altrettanto può esserlo il pretendere che egli dimostri l’insufficienza del patrimonio residuo del debitore rispetto alle sue ragioni: egli non può essere al corrente dell’esatta situazione patrimoniale del proprio debitore (né tanto meno è tenuto a farlo, se non per motivi di autotutela) e, anche in ragione di tale ignoranza, ricorre allo strumento di tutela preventiva del suo diritto.
Si delineano due diverse concezioni le quali risentono della stessa nozione di pregiudizio. Il giudizio sulla ricorrenza di esso nelle due ipotesi si atteggia in maniera profondamente diversa, nel primo caso presentandosi assai articolato (stante la necessità di un simultaneo apprezzamento di una serie di elementi), nel secondo caso esaurendosi nell’accertamento della capienza o meno del patrimonio residuo.
Stante la ricostruzione effettuata nella sentenza in commento, il Giudice dovrebbe prescindere (a meno che essa non sia rilevabile ictu oculi) dal valutare se vi sia, nel caso oggetto del suo esame, l’incapienza del patrimonio del debitore, concentrandosi al contrario – con un apprezzamento discrezionale e tipicamente di merito – sulla sostenibilità delle deduzioni del creditore revocante alla luce degli elementi prodotti in giudizio.
Lo stesso Giudice acquisisce, in tale ottica, un ruolo di assoluta centralità – in coerenza del resto con il fatto che il creditore agisce a tutela di interessi e ragioni egoistici – nell’apprezzare gli elementi da questo dedotti in causa. La delicatezza dell’apprezzamento a cui è chiamato il Giudice si rivela particolarmente elevata specie ove si consideri, normalmente, la prova dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. viene raggiunta per mezzo di presunzioni ([1]).
A conferma dell’essenzialità del ruolo del Giudice si pone la circostanza che l’apprezzamento circa la presenza di una lesione rilevante della garanzia patrimoniale deve essere condotto caso per caso, al fine di addivenire a dei risultati equi; del tutto erroneo si rivela, al contrario, ogni tentativo volto ad imbrigliare la discrezionalità sottostante a tale valutazione, magari con la previsione di criteri di valutazione predeterminati (basti pensare alla proposta di attribuire un valore convenzionale al denaro od agli altri beni che offrono un’inappagante garanzia per le ragioni creditizie) ([2]).
In un tale quadro infine sembra esservi uno spazio, non irrilevante, anche per eventuali iniziative del debitore, ben potendo questi dimostrare che il suo patrimonio residuo sia assolutamente sufficiente e solido, tale comunque da fronteggiare qualsiasi esecuzione o aggressione e da soddisfare le ragioni dei suoi creditori. Tuttavia una tale iniziativa sarebbe residuale nel senso che non sempre la dimostrazione della assoluta capienza del patrimonio residuo potrebbe comportare la conseguenza della piena efficacia dell’atto impugnato.
Sarebbe peraltro auspicabile che i Giudici manifestassero una certa elasticità di giudizio laddove, pur essendo l’atto revocabile, il patrimonio del debitore si manifesti tale da poter garantire senza alcun problema e senza il rischio di spiacevoli sorprese le ragioni del creditore attore (tenendo conto, se del caso, anche dell’esistenza di altre ragioni di credito vantate da soggetti che non abbiano agito ex art. 2901 c.c.) ([1]).
Dalla ricostruzione operata dalla Suprema Corte emerge la natura cautelare dell’azione pauliana: il creditore, in presenza del pericolo di un danno alle sue ragioni, esperisce il rimedio in questione, deducendo una serie di elementi (rilevanti al fine della delineazione della pericolosità dell’atto impugnato), la cui fondatezza deve essere accertata dal giudice di volta in volta designato; il debitore, ove in possesso di rilevanti elementi che possano smascherare la temerarietà di una tale iniziativa, li deduce in giudizio, fornendo la prova della piena capienza del suo patrimonio e dell’esigua modificazione subita dallo stesso in conseguenza dell’atto di dismissione.
Il Giudice, tenuto conto delle risultanze istruttorie, decide, con un rilevante margine di discrezionalità, nel senso del rigetto o dell’accoglimento della domanda.
Nella contrapposta impostazione, invece, si tende a negare la natura propriamente cautelare dello strumento di tutela in analisi, riconoscendogli quella esclusivamente conservativa (o al limite reintegrativa); si segnala, di conseguenza, l’esigenza di distinguere il requisito dell’eventus damni di cui al 2901 c.c. da quello del periculum in mora, richiesto al fine dell’esperibilità del sequestro conservativo, al quale, esclusivamente, andrebbe riconosciuta vera e propria natura cautelare ([2]).
Onde evitare un’inutile sovrapposizione dei due strumenti si renderebbe necessario ravvisare – in maniera restrittiva – la ricorrenza del «pregiudizio» solo laddove il rimedio del sequestro di cui all’art. 2905 c.c. rischi di rivelarsi inutile od inefficace. La teoria citata, infatti, sostiene che, nell’ipotesi in cui si volesse rispettare la reale ratio dello strumento de quo, vi si dovrebbe ricorrere solo per porre rimedio a delle situazioni pregiudizievoli già determinatesi, dovendosi chiedere l’emissione di un sequestro conservativo nei diversi casi in cui si debba solo prevenire il verificarsi di esse (in presenza, cioè, del «fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito») ([3]). Nel caso dell’alienazione di un immobile in cambio della corrispondente somma di denaro, pertanto, non potrebbe reperirsi un’ipotesi di «pregiudizio» fin quando non vi sia stata effettiva distrazione od occultamento della stessa (ossia una situazione alla quale porre rimedio) ([4]): stante, dunque, la ricorrenza di un mero periculum in mora, si dovrebbe richiedere l’emissione del sequestro conservativo, la cui finalità è proprio quella di impedire che il paventato occultamento si produca. La dottrina citata pone in evidenza come una tale posizione si manifesterebbe più rispettosa della posizione del terzo acquirente, il quale verrebbe ad essere coinvolto dalle vicende relative al proprio dante causa solo ove strettamente necessario.
Il rischio paventato dalla riportata dottrina di una sovrapposizione tra differenti rimedi giuridici non può però ritenersi fondato, dal momento che, da un lato, essa si rivela solo parziale e, dall’altro, si traduce in una pluralità di mezzi di tutela a disposizione del creditore.
Le temute sovrapposizioni si rivelano a ben guardare assai limitate, stante il fatto che i due strumenti altro non sono se non due diverse contromisure approntate dal legislatore a differenti fonti di potenziale danno.
Il sequestro conservativo vale ad eliminare la possibilità che il debitore con dei comportamenti materiali occulti, celi o distrugga determinati beni; l’azione pauliana, al contrario, con un intervento a monte, vale a rendere inefficace (nei confronti del solo creditore revocante) l’atto giuridico di disposizione che ha permesso l’ingresso nel patrimonio del debitore del bene occultabile. Solo da un punto di vista descrittivo, pertanto, possono essere accostate le conseguenze derivanti dal ricorso ad uno dei due mezzi di tutela, dovendosi al contrario ritenere che il creditore scelga tra gli stessi in funzione dell’opportunità di aggredire le somme di denaro entrate nel patrimonio del debitore piuttosto che i beni alienati ad un terzo nel cui patrimonio siano confluiti o viceversa.
Appare evidente la circostanza che, nella prospettata ipotesi dell’alienazione di bene immobile in cambio di una somma di denaro, il creditore si tuteli innanzitutto dagli effetti negativi derivati dall’atto di dismissione (l’ingresso stesso di un bene occultabile in cambio di altro dotato di maggiore stabilità e suscettibile di essere più facilmente perseguito): l’unico rimedio possibile, su tale piano, è costituito dall’azione pauliana, che è l’antidoto naturale contro le modificazioni quantitative o qualitative apportate al patrimonio dal proprio debitore con degli atti giuridici; che poi, dal punto di vista pratico, il patrimonio risulti, in conseguenza dell’atto impugnato, costituito anche da una somma di denaro (o da altro bene), che potrebbe essere resa relativamente indisponibile con il sequestro conservativo, è situazione ulteriore che non esclude l’esistenza del «pregiudizio» (specie se inteso in senso ampio) di cui all’art. 2901 c.c.
Se ne evince che il legislatore ha ritagliato per i due mezzi di tutela del credito degli ambiti di operatività distinti, anche se suscettibili di sovrapporsi parzialmente: basti pensare che la revocatoria ordinaria per essere esperita richiede il presupposto di una modificazione del patrimonio del debitore (che nel sequestro non è richiesta).
Nei casi in cui i due strumenti di tutela del credito appaiono entrambi esperibili, la scelta di uno di essi non determina l’inammissibilità di un ricorso all’altro: ciò è dimostrato dal fatto che il creditore potrebbe chiedere il sequestro conservativo della somma di denaro entrata nel patrimonio del proprio debitore, nelle more del giudizio instaurato ai fini della revoca dell’atto impugnato, atteso che per la concessione della prima misura di tutela del credito occorre un tempo di solito minore. Tale possibilità sembra essere indirettamente (ancorché testualmente) confermata proprio dall’art. 2905 2° comma, nel quale si dispone che «il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione» : il silenzio della norma, in tal caso, sembra essere dovuto alla pacifica esperibilità di entrambe le misure di tutela del credito nei confronti del debitore, che abbia compiuto l’atto pregiudizievole.
Nei casi di sovrapposizione tra i due strumenti di tutela del credito sembra esservi in capo al creditore la possibilità di scelta tra gli stessi, avendo egli la possibilità di optare per il mezzo dal medesimo ritenuto preferibile in base alle circostanze ed ad ulteriori valutazioni di opportunità. Non ne può, al contrario, derivare un limite al ricorso all’azione pauliana (e la necessità di adottare un concetto di pregiudizio ancor più restrittivo di quello in generale indicato dall’avversata dottrina di cui sopra) specie in ragione del fatto che il terzo, del quale si dovrebbe tenere conto, era (sempre che l’atto sia considerato revocabile) consapevole del pregiudizio arrecato al creditore con l’atto impugnato: non ricorre nel caso di specie quell’esigenza di tutela del terzo (che nella specie non può essere in buona fede), al contrario fortemente sentita dal legislatore in altre e ben diverse ipotesi ([1]).
Alla luce delle considerazioni appena operate, le indicazioni fornite dalla dottrina citata vanno intese sostanzialmente come uno stimolo per la giurisprudenza a mitigare certe posizioni, talvolta troppo favorevoli al creditore ed estremamente penalizzanti le ragioni del debitore e del terzo acquirente.
Tuttavia si deve ribadire che non sembrano le strade indicate da tale dottrina minoritaria quelle idonee a modificare gli attuali orientamenti giurisprudenziali: né la soluzione nel senso auspicato del problema di metodo relativo ai criteri di valutazione del patrimonio del debitore, né tanto meno la definizione dei rapporti tra l’azione revocatoria ordinaria ed il sequestro conservativo, fondata sul sollevamento di steccati nell’impiego dei due strumenti non rinvenibili nelle norme codicistiche.
I suggerimenti operati ex adverso si rivelano, ben guardare inadeguati, in quanto incidenti sul profilo metodologico (rapporti tra criteri qualitativi e quantitativi, da un lato e tra azione revocatoria e sequestro conservativo, dall’altro) e non sostanziale, tentando di offrire delle soluzioni che – non riscontrabili nel dato normativo – avrebbero il principale effetto di imbrigliare l’apprezzamento operando dal giudice, il quale invece deve essere improntato ad una notevole discrezionalità proprio al fine di ottenere i risultati più equi possibili. La restrizione a cui sembra aspirare la teoria citata ad altro non sembra in sostanza poter condurre se non ad un ritorno a posizioni da tempo superate dalla nostra giurisprudenza, delle quali ci si occuperà di qui a poco. - Le ultime considerazioni effettuate costituiscono lo spunto per avvicinarsi alla questione, sin dall’inizio anticipata, relativa alla qualificazione che del concetto di «pregiudizio» può essere operata in astratto: esso può, infatti, essere inteso sia come danno attuale e concreto subito dal creditore in conseguenza della realizzazione dell’atto di disposizione sia come pericolo di un danno emergente in una futura nonché eventuale esecuzione forzata dell’obbligazione del debitore.
Tale problematica, la cui diversa soluzione invero non determina conseguenze rilevanti dal punto di vista pratico ([1]), si traduce in un problema di qualificazione giuridica del su citato pregiudizio.
Va rilevato, ad onor del vero, che essa viene risolta in maniera pressoché unanime dalla giurisprudenza e dalla dottrina predominanti ([2]) le quali concordano nel ritenere che l’azione revocatoria o pauliana valga a tutelare il creditore dal rischio (da ciò conseguendo il c.d. periculum damni, richiesto per il suo esercizio) che, in un’eventuale esecuzione forzata, il patrimonio del debitore – in conseguenza di atti di disposizione anteriori o successivi al sorgere del credito – si riveli insufficiente a soddisfarne gli interessi.
Sennonché non è mancato chi, sulla scorta di alcune – seppur discutibili – argomentazioni, ha asserito che il creditore, all’atto della dismissione realizzata dal proprio debitore, subirebbe un danno concreto ed attuale, consistente nella lesione (senz’altro immediata) della garanzia patrimoniale costituita dai beni dei debitori ([1]).
In altri termini, sarebbe necessario distinguere tra la lesione della garanzia patrimoniale ed il danno, emergente in una fase successiva ed eventuale, costituito dalla mancata (piena) soddisfazione delle ragioni creditizie in sede di un’esecuzione forzata dell’obbligazione del debitore.
Tale dottrina minoritaria argomenta tale conclusione facendo leva essenzialmente su due elementi, di cui uno di carattere storico, l’altro di diritto positivo.
Dal primo punto di vista, si sostiene che ad una tale conclusione dovrebbe condurre l’analisi dell’evoluzione subita dall’azione pauliana nel corso dell’ultimo secolo, ossia da quando questo strumento di tutela del credito – conosciuto peraltro già dai giuristi dell’antica Roma – è stato impropriamente regolamentato dall’art. 1235 c.c. 1865: tale norma, com’è noto, nel disciplinare la revocatoria non prevedeva tra i presupposti del suo esercizio quello dell’eventus damni ([2]).
L’omissione di una tale previsione non impedì alla giurisprudenza ed alla dottrina predominanti di richiedere – pur nel silenzio della legge – la presenza ai fini del legittimo esercizio della azione pauliana del requisito stesso, identificato però (in maniera assai restrittiva) con l’insolvenza assoluta del debitore ([3]).
La concretizzazione così operata di tale requisito oggettivo determinava, però, un’estrema rigidità dello strumento di tutela de quo, esercitabile solo ove si fosse già inutilmente esperita un’azione esecutiva nei confronti del debitore.
In un secondo momento, dunque, la giurisprudenza – sulla spinta della dottrina maggioritaria dell’epoca – richiese quale presupposto per l’esperibilità della pauliana la dimostrazione dell’insolvenza solo relativa del debitore ([4]). Tale secondo orientamento giurisprudenziale è stato recepito pressoché in toto dal legislatore del ’42, il quale ha risolto le questioni sorte in conseguenza dell’approssimativa formulazione dell’art. 1235 (c.c. 1865) attingendo ampiamente alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza precedente ([5]): tutt’altro che casuale appare, quindi, il fatto che il legislatore, nell’alludere all’eventus damni, abbia impiegato il termine di «pregiudizio» piuttosto che qualche altro meno generico ([6]).
L’evoluzione citata ha avuto senz’altro il merito di produrre un progressivo sganciamento della revocatoria ordinaria dalla fase esecutiva, facendo acquistare alla prima il carattere di strumento di tutela preventiva del credito ([1]).
Ebbene la dottrina minoritaria in esame trae da tale separazione tra le due fasi di tutela la conclusione che, con l’esercizio della revocatoria, si tuteli un interesse differente da quello che trova una soddisfazione (o una mortificazione) in fase esecutiva (ossia l’interesse del creditore di essere comunque soddisfatto). Essa ne deduce, ulteriormente, che un atto di disposizione di parte del patrimonio del debitore, ledendo quell’interesse produca un danno attuale e tutt’altro che futuro.
Sul versante del diritto positivo, d’altro canto, la tesi citata trova delle argomentazioni nell’espresso riconoscimento dell’esperibilità dell’azione revocatoria anche in presenza di crediti a termine o condizionali. Si osserva che se il pregiudizio da accertare in relazione ad essi consistesse nel mero pericolo di un danno futuro, il giudice finirebbe per introdurre, nella valutazione in merito alla ricorrenza del requisito oggettivo, anche quella circa la possibilità che il debitore ridivenga solvente prima della scadenza del termine o circa la possibilità di avveramento della condizione ([2]).
Entrambe le argomentazioni di forza della dottrina in esame sono a ben guardare assai deboli.
Sotto il primo profilo, del tutto incomprensibile appare la conclusione alla quale addiviene l’orientamento esaminato: non può, infatti, trascurarsi la differenza tra l’esercizio di un’azione o potere ([3]), e la situazione di eventuale svantaggio contro la quale essa venga esercitata.
Se è vero, infatti, che la revocatoria può oggi essere esperita – in conseguenza dell’evoluzione brevemente ripercorsa sopra – indipendentemente dal previo esercizio di un’azione esecutiva, non è altrettanto vero che tale sganciamento abbia evidenziato un autonomo interesse del creditore da tutelare e, men che mai, un danno attuale e concreto, diverso da quello patibile in sede di esecuzione forzata ([4]), da scongiurare con il ricorso alla azione de qua. Solo l’esigenza di rendere lo strumento in esame il più efficace possibile ha indotto la giurisprudenza a rivedere i propri orientamenti e non certo il configurarsi di un pregiudizio diverso da quello che istituzionalmente lo stesso è chiamato a combattere: se così non fosse vi sarebbe uno snaturamento dello strumento di tutela preventiva del credito e non una sua semplice evoluzione in melius.
Sempre dal punto di vista teorico, la dottrina in esame sembra ingenerare un assoluto appiattimento delle differenze esistenti tra il principio della responsabilità ex art. 2740 c.c. e la garanzia patrimoniale del creditore ([1]), ingenerando quasi un’assimilazione della seconda al primo.
Tali concetti anche se strettamente interrelati sono facilmente differenziabili tra di loro, stante il fatto che solo la responsabilità crea un effettivo vincolo di destinazione sui beni del debitore inadempiente: la garanzia generica, sottostante alle norme di cui agli artt. 2900 c.c. e ss., non è assimilabile ad una situazione giuridica soggettiva autonoma in capo al creditore e dunque non può essere distinta dal diritto soggettivo di credito, di cui questi sia titolare ([2]).
Ritenere, quindi, che il creditore possa subire un danno attuale e concreto in conseguenza di un atto di disposizione significa, in un certo qual modo, equiparare la garanzia generica, fornita dal patrimonio del debitore in pendenza di un rapporto obbligatorio, alla responsabilità (specifica) ottenuta (ad adempimento già verificatosi) dall’aggressione dei singoli beni che appartengono al patrimonio stesso ([3]).
Tali due concetti o principi implicano una diversità di momenti del rapporto obbligatorio, il primo (la garanzia) collocandosi nella sua c.d. fase fisiologica, in cui il creditore ancora spera nell’adempimento o non ha, nell’ipotesi in cui esso si sia già verificato, ancora intrapreso un’azione esecutiva ([4]). La responsabilità patrimoniale è principio che trova la propria collocazione principale nell’eventuale fase patologica del rapporto, ossia nell’ipotesi in cui al creditore non rimanga altra via che quella dell’esecuzione coattiva dell’obbligazione (fino ad allora inadempiuta) per soddisfare le proprie ragioni.
Il creditore, d’altronde, fin quando non vi sia inadempimento ha interesse a che il debitore effettui la propria prestazione obbligatoria, essendo condotto, solo per ragioni di cautela, a vigilare sulla conservazione dell’integrità della garanzia patrimoniale.
D’altronde, specie nell’ipotesi in cui non vi sia stato inadempimento, l’interesse del creditore ha ancora possibilità di essere soddisfatto sia mediante l’effettuazione della prestazione da parte del debitore, sia per mezzo dell’aggressione dei suoi beni.
In tale ipotesi, quindi, il danno è doppiamente eventuale in quanto non solo vi è ancora la possibilità che l’obbligazione si estingua con il perfetto soddisfacimento del creditore, ma vi è in ogni caso (nell’eventualità di un inadempimento) la possibilità che, in sede di esecuzione coattiva, l’interesse stesso trovi comunque una soddisfazione.
Sotto tale profilo, dunque, la teoria esaminata che qualifica attuale il danno subito in conseguenza di una lesione (essa sì concreta) della garanzia patrimoniale sembra determinare conseguenze dal punto di vista sistematico che non possono essere accettate.
Se la prima argomentazione utilizzata dalla dottrina avversata non sembra meritevole di particolare considerazione, specie alla luce delle sua insostenibilità da un punto di vista teorico, la seconda (di natura positiva) non sembra potere godere di sorte migliore: essa, infatti, si basa sulla presunzione, priva di alcun riscontro concreto, che ogniqualvolta i giudici siano chiamati a verificare se un atto dispositivo possa aver arrecato pregiudizio ad un creditore a termine o condizionale, finirebbero per verificare se vi sia la possibilità che la situazione d’incapienza eventualmente ingeneratasi sia o meno superabile prima che il credito diventi esigibile, piuttosto che analizzare se – alla luce dei dati in possesso a quel momento – esso sia concretamente esistente e comporti la revocabilità dell’atto impugnato. Fino a prova contraria, non sembra esservi alcun elemento che possa indurre a dubitare che i giudici, anche in tal caso, provvederebbero (ed in concreto provvedano) ad effettuare un apprezzamento del pregiudizio, utilizzando i medesimi criteri impiegati nei casi in cui la lesione della garanzia interessi un credito esigibile.
Alla luce delle considerazioni finora effettuate, sembra essere esatta la configurazione dell’eventus damni come mero periculum e non può, nel contempo, essere condivisa la distinzione che, in parte sembra emergere dalla sentenza in commento tra l’effetto prodotto dall’atto dispositivo che abbia diminuito radicalmente il patrimonio da quello che ne abbia alterato qualitativamente le componenti. In entrambi i casi il danno, infatti, è solo potenziale, anche nel caso in cui il patrimonio abbia subito un’ingente diminuzione tale da farlo scendere al di sotto della soglia della capienza : l’unica differenza in tal caso sembra potersi ravvisare nel fatto che il «pregiudizio» risulta essere più evidente o più immediatamente percepibile, trattandosi di situazione apprezzabile solo in termini squisitamente oggettivi.
Premesso infatti che il rapporto obbligatorio, nell’una come nell’altra ipotesi, si presenta ancora nella sua fase fisiologica, si deve escludere la qualificazione del pregiudizio come danno attuale, stante il fatto che il momento di emersione del danno non può essere altro che quello dell’eventuale esecuzione forzata. Solo in tale sede l’incapienza (magari determinatasi già precedentemente) può determinare delle conseguenze effettivamente negative e dannose per il creditore.
Ne deriva, in definitiva, l’inopportunità di differenziazioni tra le diverse gradazioni di pregiudizio, che risultino fondate sulla maggiore o minore evidenza all’esterno del pregiudizio: la facilità con cui risulti apprezzabile il requisito oggettivo di cui all’art. 2901 c.c. non si traduce, infatti, in una maggiore pericolosità dell’atto di disposizione volta a volta impugnato.
[1] Cfr., in senso conforme alla sentenza in commento, varie pronunce di legittimità, tra le quali Cass., 10 ottobre 1997, n° 3113, in Giust. Civ. Mass., 1997; Cass., 10 luglio 1997, n° 6272, ivi; Cass., 8 febbraio 1996, n° 997, in Giust. Civ. Rep., 1996; Cass., 15 giugno 1995, n° 6777, ivi, 1995; Cass., 22 marzo 1990, n° 2400, in Corr. Giur., 1990, 609 e in Giur. It., 1991,I,1, 464; Cass., 1 dicembre 1987, n° 8930, ivi, 1987; Cass., 1 aprile 1987, n° 3126, ivi; Cass., 17 gennaio 1984, n° 402, ivi, 1984. Per ulteriori riferimenti, anche se su una problematica parzialmente diversa, cfr. Costanza M., Atto di disposizione, eventus damni, e nesso di causalità, (nota a Cass., 27 novembre 1982, n° 6475), in «questa Rivista», 1983, I, 1176. Per dei riferimenti ancora più risalenti cfr. Cass., 27 maggio 1977, n° 2180, in «questa Rivista», 1977, I, 1304.
Per la giurisprudenza di merito, su fattispecie di volta in volta differenti, cfr. Trib. Nocera Inferiore, 14 marzo 1996, in Giur. Merito, 1997, 294 (con nota di Solaini); Trib. Roma, 22 marzo 1994, in GIUS, 1994, fasc. 14, 147, (con Nota di Masucci); Trib. Catania, 27 maggio 1993, in Dir. Famiglia, 1994, 1263; Trib. Napoli, 16 marzo 1991, in B.B.T.C., 1992, II, 605 (con nota di Baruzzi); Trib. Napoli, 16 giugno 1988, in B.B.T.C., 1989, II, 469 (con nota di Inzitari); Trib. S. M. Capua Vetere, 3 aprile 1984, in Nuovo Diritto, 1985, 37 (con nota di Manera).
[2] Tra i tanti Autori che hanno assunto una tale posizione si citano, in maniera non esaustiva, C. Cossu, voce «Revocatoria ordinaria (azione)», in «Dig. Disc. Priv. Sez. Civ.», vol. XVII, 1998, 451 ss.; V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, in Tratt. Dir. Priv., diretto da Rescigno, XIX, Torino, 1997, 503 ss.; F. Gazzoni, Manuale di Diritto Privato, 6ª ed., 1996, Napoli, 649 ss.; C.M. Bianca, Diritto Civile, La responsabilità, V, Milano, 1994, 433 ss.; L. Bigliazzi Geri, voce «Revocatoria (azione)», in «Enc. Giur. Treccani», XXVII, Roma, 1991; Roselli, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, Torino, 1990, 207 ss.; D’Ercole, L’azione revocatoria, in Tratt. Dir. Privato, diretto da Rescigno, Torino, 1985, 145 ss.; R. Nicolò, Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, in Comm. Cod. Civ. Scialoja–Branca, art. 2900–2969, Bologna–Roma, 1960, 181 ss.; U. Natoli, voce «Azione revocatoria ordinaria», in «Enc. Diritto», IV, Milano, 1959, 888 ss..
[3] Cfr. E. Lucchini, L’eventus damni nelle revocatorie, Pavia, 1993, 180 ss., ove l’Autore asserisce che il debitore deve, alla luce delle posizioni consolidate della giurisprudenza, garantire: a) «la fruttuosità dell’esecuzione» assicurata evitando il verificarsi di uno «scompenso negativo» all’interno del patrimonio; b) «la certezza dell’esito dell’esecuzione» garantita dalla presenza di «beni stabili» all’interno del patrimonio stesso; c) «lo stesso grado di agevolezza della procedura esecutiva» evitando il «peggioramento delle condizioni di svolgimento dell’eventuale procedura esecutiva».
[4] Piuttosto il problema, di non poco peso, che si pone in merito a tale tipologia di atti dispositivi e di effetti da essi prodotti attiene al modo in cui applicare il criterio quantitativo citato: si può, infatti, valutare il patrimonio del debitore sia includendo che escludendo le passività costituite dai crediti vantati da soggetti diversi da quello del creditore revocante. Le conseguenze che si possono porre al riguardo, con la revoca o meno del medesimo atto, solo in funzione della diversa valutazione effettuata dal giudice adito sono ben messe in luce da E. Lucchini, op. cit., 193 ss., il quale propende per la valutazione “ampia” (ivi comprese le passività costituite da debiti diversi da quello verso il revocante) del patrimonio, al fine di una tutela più efficace dello stesso. Nel senso che si debba aver riguardo nel giudizio sulla revocabilità dell’atto dispositivo impugnato alla «situazione economica generale del debitore» cfr. Roselli, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, cit., specie 208 nonché Cossu, C., voce «Revocatoria ordinaria (azione)», in Dig. Disc. Priv. Sez. Civ., cit., 465.
[5] Come si avrà modo di precisare più innanzi, sotto la vigenza del codice civile del 1865 l’eventus damni veniva, in concreto, ravvisato da parte di una consistente giurisprudenza nella c.d. insolvenza assoluta del debitore, dimostrata con il preventivo ricorso ad un’azione esecutiva rimasta evidentemente infruttuosa.
[6] Parte della dottrina evidenzia come la considerazione dei beni immobili come gli unici a fornire una efficace garanzia per il creditore dovrebbe essere assoggetta a profonda revisione, tenuto conto delle forme di investimento del danaro oggi in voga anche presso i piccoli risparmiatori. Un invito in tal senso si rinviene sia in C. Cossu, voce «Revocatoria ordinaria (azione)», in «Dig. Disc. Priv. Sez. Civ.», cit., 454, il quale afferma l’esigenza di reperire un «nuovo equilibrio» tra le contrapposte esigenze delle parti del rapporto obbligatorio, «su una linea che non mortifichi le esigenze del debitore, assicurandogli spazi di libertà oggi indispensabili per gli attuali modi dell’agire economico»; sia in E. Lucchini, op. cit., 208 ss., ove l’Autore (213) evidenzia come la considerazione del solo patrimonio immobiliare, quale unica forma di effettiva garanzia del credito, comporti delle conseguenze assai negative specie per le imprese, costrette a ricorrere (al fine di evitare le poco auspicabili conseguenze derivanti da siffatta interpretazione dell’art. 2901 c.c.) a delle «immobilizzazioni», rinunciando a quella continua circolazione del loro capitale che invece si rivela per le stesse necessaria.
[7] In tal senso E. Lucchini, op. cit., 191 ss.
[8] Cfr. E. Lucchini, op. loc. ult. cit.
[9] Si dovrebbe concludere con la teoria in esame che – una volta stabilito che il valore del denaro sia nullo, alla luce della sua incapacità di fornire garanzie al creditore – il patrimonio pari a 100, costituito esclusivamente di somme liquide entrate in sostituzione di un bene immobile, assumerebbe, in virtù dell’applicazione del primo criterio qualitativo (sub b), un valore contabile di 0. Stante il fatto che il valore del credito, in ipotesi pari a 25, sia divenuto superiore a quello del patrimonio (da ritenersi pari a 0), ne scaturirebbe la inevitabile revocabilità dell’atto.
[10] D’altronde, nella prospettiva dal medesimo Autore, appare chiaro che la valutazione circa la ricorrenza del pregiudizio debba tradursi in una stima di carattere quantitativo, tale da portare alla luce un pregiudizio solo ove il patrimonio residuo valutato in termini quantitativi (o qualitativi prima e quantitativi poi) si riveli insufficiente.
[11] La dottrina predominante non ha dedicato alla tematica della prova dell’eventus damni particolare attenzione, limitandosi, in assenza di specifiche norme in merito, a richiamarsi alla disciplina generale di cui agli artt. 2697 ss. c.c. : a titolo esemplificativo si veda R. Nicolò, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, in Comm. Cod. Civ., a cura di Scialoja – Branca, cit., 218 ss.
[12] Cfr. sul punto Cass., 17 novembre 1976, n° 4278, in «questa rivista», 1977, I, 1405 ; più in generale, in ordine alla prova per presunzioni in tema di revocatoria Cass., 8 giugno 1983, n° 3937, in Giust. Civ. Mass., 1983 ; Cass., 21 ottobre 1982, n° 5488, ivi, 1982 ; Cass, 29 giugno 1981, n° 4207, ivi, 1981 ; Cass., 5 marzo 1980, n° 1482, ivi, 1980.
[13] Sulla necessità che il giudice provveda ad un accertamento caso per caso del «pregiudizio» cfr. D’Ercole, L’azione revocatoria, in Trat. Dir. Priv., diretto da P. Rescigno, cit., specie 149.
[14] Interessanti, al riguardo, le considerazioni di V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, in Tratt. Dir. Priv., diretto da P. Rescigno, cit., specie 505, il quale evidenzia come il «principio di universalità della responsabilità patrimoniale (…) deve combinarsi con un principio di proporzionalità o di adeguatezza», in base al quale «la misura dell’incidenza della responsabilità non può non essere in funzione dell’entità dei debiti stessi» ; l’Autore specifica che tale principio di adeguatezza deve trovare la propria applicazione non solo nella fase dell’attuazione della responsabilità, ma anche quando la responsabilità medesima sia ancora potenziale.
[15] In tal senso E Lucchini, op. cit., 247 ss.
[16] Così, Lucchini, op. loc. ult. cit.
[17] Sulla rilevanza e fondatezza della «obiezione di fondo» riportata nel testo cfr. Bianca C.M., Diritto civile, La responsabilità, V, cit., 440, nota 23.
[18] Basti pensare, a puro titolo esemplificativo, all’ipotesi dell’acquisto a non domino.
[19] Del medesimo avviso è anche E. Lucchini, op. cit., specie 171. A conferma di quanto asserito nel testo basti pensare che il principale assertore della tesi del pregiudizio quale danno attuale e concreto alle ragioni creditizie, A. Maffei Alberti, Il danno nella revocatoria ordinaria, Padova, 1970, specie 25 ss., finisce per ritenere revocabile, al pari della tesi opposta, l’atto di disposizione con il quale il debitore abbia prodotto un’alterazione essenzialmente qualitativa del patrimonio e non necessariamente quantitativa.
[20] Si rimanda alla elencazione di pronunce di legittimità e di merito e a quella, non esaustiva, della dottrina più autorevole, di cui alle note 1 e 2.
[21] Cfr., A. Maffei Alberti, op. cit., 18 ss.
[22] Sulla necessità della ricorrenza dell’eventus damni, asserita sin da tempi remoti, al fine dell’esercitabilità dell’azione de qua, cfr. ancora E. Lucchini, op.cit., specie 57 ss., il quale tra l’altro osserva che, anche sul piano logico, ammettere che la revoca di un atto possa essere pronunciata in assenza del requisito citato «significherebbe permettere al creditore di porre in essere legittimamente degli atti emulativi nei confronti del suo debitore».
[23] Sul Punto cfr. Maffei Alberti, op. cit., 8 ss.
[24] Rileva Maffei Alberti, op.cit., che in quella seconda fase, «presupposto oggettivo dell’azione revocatoria non veniva considerato il danno attuale certo assoluto e determinato, ma più genericamente ogni difficoltà creata con l’atto fraudolento al creditore nel (futuro) soddisfacimento delle ragioni creditorie».
[25] Una descrizione delle numerose interrelazioni – esistenti tra la soluzione normativa adottata, in tema di revocatoria, dal legislatore del ’42 ed i problemi dibattuti, sotto il vigore del codice precedente, dalla giurisprudenza – si rinviene in R. Nicolò, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, cit., 181 ss.; sul tema oggetto della presente analisi cfr., più specificamente, 216 ss.
[26] Cfr., in proposito, E. Lucchini, op.cit., specie 245, il quale ritiene la scelta operata dal legislatore addirittura «obbligata», stante il fatto che dato l’ampio significato del termine pregiudizio «in esso si può ricomprendere sia una situazione genericamente e potenzialmente pregiudizievole per i creditori, sia anche l’insolvenza ottocentesca» (già esaminata sopra nel testo).
[27] Appare pacifico il fatto che l’azione pauliana possa, ancora oggi, essere esercitata anche a seguito dell’esercizio di un’azione esecutiva che non abbia prodotto gli effetti sperati, atteggiandosi, nell’ipotesi, a rimedio di carattere successivo. Tale ruolo della revocatoria è a tutt’oggi senz’altro residuale: in tal senso Lucchini, op. cit., 245 ss.
[28] Così Maffei Alberti, op. cit., 19.
[29] I limiti della presente analisi impediscono di analizzare la questione (peraltro risalente) della natura dell’azione revocatoria e della sua collocazione tra le azioni (diritto processuale) o tra i diritti (diritto sostanziale). Si segnala, peraltro, al riguardo l’autorevole posizione assunta da C.M. Bianca, Diritto civile, La responsabilità, V, cit., specie 437, secondo il quale il creditore sarebbe titolare di un «potere revocatorio» – esercitabile a tutela del suo interesse alla conservazione della garanzia generica – qualificabile giuridicamente come «diritto potestativo ad esercizio processuale» e pienamente assimilabile, quindi, ad una posizione di diritto sostanziale.
[30] Assai interessanti, al riguardo, le osservazioni di Bigliazzi Geri, voce «Revocatoria (azione)», in «Enc. Giur. Treccani», cit., 1, la quale esclude che l’interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale possa costituire il «presupposto di un’autonoma (rispetto al credito) situazione di vantaggio, a propria volta qualificabile come diritto soggettivo, avente a contenuto una pretesa, cui poi dovrebbe corrispondere nel debitore uno specifico obbligo di mantenere nel proprio patrimonio una quantità di beni sufficienti ad assicurare che, in caso di inadempimento dell’obbligazione principale, il creditore possa ottenere coattivamente l’equivalente pecuniario della prestazione».
[31] Sulla problematica cfr. C. Cossu, voce «Revocatoria ordinaria (azione)», in «Dig. Disc. Priv. Sez. civ.», cit., 452 ss., ove peraltro l’Autore sottolinea che «la responsabilità non coincide con la garanzia. Del tutto improprio è pertanto riferire delle condotte del debitore come suscettibili di diminuire la sua responsabilità. Questa non può non rimanere inalterata (assurdo che essa possa diminuire per fatto dell’obbligato). Gli atti del debitore possono incidere in effetti non sulla sua responsabilità ma sulla sua “capacità di rispondere”, che è quanto dire sulla sua garanzia patrimoniale».
[32] Al riguardo cfr. i puntuali rilievi di C. Miraglia, voce «Responsabilità patrimoniale», in «Enc. Giur. Treccani», XXVII, Roma, 1991, 4 ss., la quale tra l’altro sottolinea il fatto che se è vero che il creditore, attraverso i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, può legittimamente ingerirsi nella sfera degli interessi del debitore, nessuna norma, dall’altra parte, impone esplicitamente a carico di questi un obbligo di astenersi dall’effettuare atti dispositivi, al limite lesivi della garanzia patrimoniale e quindi pregiudizievoli per le ragioni creditizie.
[33] In dottrina, per la verità, non mancano orientamenti volti a sostenere che la responsabilità patrimoniale verrebbe in gioco prima dell’inadempimento ed indipendentemente da esso (questione che esula, con tutta evidenza, dall’oggetto della presente trattazione).
[34] Cfr., sul punto, le efficaci osservazioni di F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., 620. D’altronde, non sembra si possa far riferimento, al fine di giustificare un’anticipazione della responsabilità alla fase dello svolgimento fisiologico del rapporto obbligatorio, alla teoria di derivazione tedesca che ritiene l’obbligazione costituita dalle due componenti di debito e responsabilità, secondo la quale il debitore con l’assunzione dell’obbligazione si assoggetterebbe contestualmente ad un vincolo di carattere personale (circa la prestazione da effettuare) e ad uno di carattere patrimoniale (la responsabilità offerta con i propri beni, a garanzia dell’inadempimento). Sul tema, cfr. per tutti C. Miraglia, voce «Responsabilità patrimoniale», in «Enc. Giur. Treccani», cit., 1, la quale rileva che l’attuale formulazione dell’art. 2740 c.c. costituisca indubbiamente un passo in avanti notevole rispetto al precedente art. 1948 del c.c. previgente, specie laddove delinea, anche se con una certa imprecisione di linguaggio, la responsabilità patrimoniale come «elemento autonomo dal dovere di prestare».
- Sulla modifica unilaterale in peius delle mansioni dopo il Jobs Act e sulle prospettive di concreto utilizzo, a fronte dei presupposti formali e sostanziali di cui all’art. 2103, commi 2 e 5, c.c. - 24 Giugno 2019
- Agenzie di somministrazione e licenziamento per g.m.o.: sulla mancanza di occasioni di lavoro di cui all’art. 25 del CCNL di settore e sui riflessi nei giudizi di impugnativa di licenziamento. Oneri di allegazione e tipo di tutela applicabile - 13 Luglio 2017
- Agenzie di somministrazione e licenziamento per mancanza di occasioni di lavoro – Tribunale di Velletri, 29 luglio 2016, est. Falcione, e Tribunale di Roma, 2 novembre 2016, est. Pagliarini - 12 Maggio 2017
- Licenziamento – Tribunale di Larino: valutazione delle sanzioni richiamate ai fini della recidiva che ha dato luogo al licenziamento - 11 Maggio 2016
- Risarcimento – Cassazione SU Civili: risarcimento del danno spettante al dipendente pubblico in caso di abuso del contratto a tempo determinato - 25 Marzo 2016
- Licenziamento disciplinare: nuove indicazioni della Corte di Cassazione sulla “insussistenza del fatto contestato” e sulla conseguente applicazione della reintegra - 30 Ottobre 2015
- Applicazione al dirigente medico dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, per effetto del CCNL ARIS ANMRIS sulla valenza delle dichiarazioni confessorie rese in sede disciplinare - 19 Giugno 2015
- Eventus Damni ed onere della prova nella revocatoria ordinaria, tra il principio della garanzia patrimoniale e la libertà di iniziativa economica del debitore - 14 Febbraio 1999
- Lavoro all’estero: scelta della legge applicabile e limite dell’ordine pubblico interno - 25 Maggio 1998