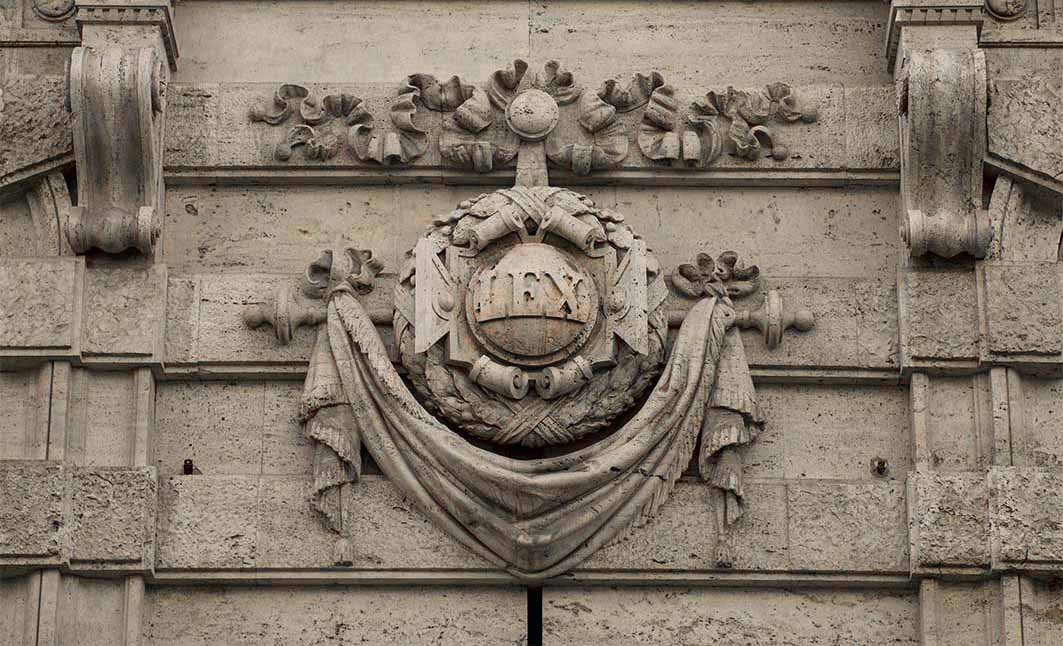Il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati il 10 marzo 2016, contenente una serie di iniziative normative per l’efficienza del giudizio civile, suscita vari spunti di riflessione, sia per il processo ordinario, sia, soprattutto, per il processo del lavoro.
Il testo, tra l’altro, all’art. 1 comma 2° sub. A) 1, indica, come “criterio direttivo”, quello di valorizzare l’istituto del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del Giudice, di cui agli artt. 185 e 185 bis del c.p.c., con forme di penalizzazione processuale per la parte a tal fine non comparsa.
Una tale previsione, che si colloca in linea con una ormai non più recente tradizione normativa di deflazione giudiziaria attuata mediante forme di intervento mediatorio del Giudice e soprattutto con quanto già codificato, per il processo del lavoro, dalla previsione di cui al primo comma dell’art. 420 c.p.c., anche alla luce delle esperienze maturate “sul campo”, deve essere, a mio avviso, ridiscussa.
La stessa infatti, più che ad un incremento di efficienza del sistema giustizia, così come ipotizzata dal Legislatore e come gestita nella prassi, viene, in concreto, ad accentuare più che a velocizzare o scoraggiare il ricorso alla Magistratura e, comunque, determina, in via indiretta, un appesantimento della funzione giurisdizionale, con superfetazione di ruoli, non sempre utile e spesso foriera di impreviste incertezze aggiuntive, ambiguità e confusione, soprattutto nelle parti (chiamate, a dispetto della funzione del difensore, a vivere personalmente tale esperimento), che hanno difficoltà a ravvedere nel Giudice, per l’appunto tradizionalmente e culturalmente identificato come colui che è socialmente chiamato a dirimere il loro caso secondo giustizia, un indefinito estremo mediatore (nella tradizione antropologica popolare italiana simile figura è sempre stata rimessa ad una “autorità” – religiosa, familiare, sociale, connotata da caratteristiche di fiduciarietà personale di entrambi le parti, ascendente, autorevolezza morale ecc.) da loro non scelto come tale e, sostanzialmente, imposto dal sistema.
Lo specifico ruolo di mediatore autorevole, peraltro, notoriamente, impone un bagaglio tecnico, sociologico e psicologico, non richiesto, né valorizzato, nei concorsi di Magistratura, e non risulta sempre gestito, in carenza di un rito codificato, con la dovuta uniformità e logica gestoria da parte dei singoli giudici o collegi, ed è spesso rimessa (più che all’autentico o quantomeno prevedibile, sostanziale punto di caduta transattivo della vertenza) a fattori diversi, quali il contenuto economico delle domande così come formulate negli atti introduttivi, la apparente complessità dell’impegno istruttorio sulla ricostruzione in fatto, le apparenti difficoltà ad affrontare le questioni giuridiche a base della domanda o delle eccezioni, al carattere, alla valutazione discrezionale e al carico di lavoro del Giudice.
Una simile azione risulta peraltro prevista dalla legge senza un filtro difensionale, ma con un rapporto diretto magistrato/parti, personalmente presenti, che vede assente o non prevista una partecipazione attiva degli avvocati, ai quali spesso, da parte dei magistrati che conducono il tentativo di conciliazione, è richiesto un passo indietro, quasi fossero i portatori di una volontà al contrasto ed elemento di intralcio ad una chiusura “gordiana” della vicenda.
Non solo. L’accentuazione della funzione mediatoria rimessa al giudice condiziona inevitabilmente la posizione degli stessi avvocati che, nella definizione della strategia in difesa del cliente, stante la codificazione del tentativo di conciliazione endoprocessuale della controversia, più che ricercare forme di accordo preventivo extragiudiziale, sono portati più a valorizzare, nell’ottica di una tattica transattiva in favore del cliente, impostazioni processuali velleitarie e temerarie delle linee difensive, che a ricercare impostazioni della domanda o della risposta difensiva che tengano conto di logiche autenticamente giuridiche.
Siamo tutti testimoni di quante richieste rivendicazioni gonfiate o richieste di danno, oggettivamente improbabili, siano sottoposte alla Magistratura nel presupposto di ottenere, anche mediante semplicistici inviti a “chiudere la controversia”, una qualche transazione e spese legali. Siamo tutti testimoni di come sia ormai prassi frequente che molti colleghi, pur consapevoli di essere in torto o comunque più che consci della ardua difendibilità della loro posizione, preferiscono adottare tattiche di contrasto spregiudicate per sparigliare le carte e perdere tempo, anche a costo di non apparire tecnicamente credibili, nell’auspicio, spesso premiato, di veder ridimensionato, con la complicità del sistema, l’obbligo della parte rappresentata ed indurre la controparte ad accettare soluzioni transattive in perdita, non per debolezza della posizione giuridica, ma esclusivamente a fronte dell’incertezza dei tempi e dei costi di una realizzazione giudiziale di un diritto.
La norma oggi discussa, anziché ridurre, implementando gli accordi, il numero dei processi che giungono a sentenza, ridimensionando quindi gli impegni decisionali dei giudici e riducendo l’arretrato, tende invece a favorire tale prassi e quindi paradossalmente ad ingigantire il contenzioso giudiziale.
L’attività di mediazione del Giudice (che rappresenta l’Istituzione), di fatto alternativa e sostitutiva della decisione, contribuisce quindi solo a rafforzare, nel cittadino, la convinzione che lo Stato non ce la fa a rendere, in monopolio, il “servizio giustizia” al quale, con tasse e contributi, il cittadino ha diritto, come sancito dall’art. 24 della Costituzione, con la conseguente conferma che l’utente, scoraggiato da una simile confessione di inefficienza del sistema (causa ed effetto del cennato fenomeno distorsivo) percepisce la chiara sensazione di una impossibile realizzazione del precetto costituzionale.
Ciò è confermato dal fatto che, spesso, sono proprio gli stessi giudici che, nel consigliare o “forzare” forme conciliative, rappresentano alle parti come l’esercizio giurisdizionale sia frastagliato di insidie e di sabbia, di costi e di tempi, aggiungendo, da parte loro, che le decisioni sono incerte, spesso riformate, insomma che non esiste la certezza del diritto e che i tempi rapidi nella riparazione dei torti sono delle chimere.
Non va sottaciuto che, a volte, i Giudici, gravati dal carico di cause, e soprattutto per vertenze lunghe, impegnative e, spesso, ereditate da altri magistrati, tendono, prima di studiare le carte, ad indurre le parti, anche con prospettazioni fosche di lunghi rinvii, nonché con inviti agli avvocati a depositare reiteratamente note (spesso solo ripetitive di quanto precedentemente dedotto), a conciliare la lite, non tanto e non solo per rispettare l’obbligo mediatorio attribuito dalla legge, quanto ad evitare l’amaro calice di dover decidere troppe cause senza il dovuto approfondimento istruttorio e motivazionale.
Come sopra osservato, la previsione normativa di cui al primo comma dell’art. 420 c.p.c., impone inoltre al Giudice del lavoro di formulare, a fronte delle mere posizioni delle parti, e senza aver approfondito la veridicità delle relative allegazioni in fatto o le posizioni in diritto, una proposta transattiva. Tale previsione normativa costituisce indubbio fattore di distorsione della delineata funzione rimessa dal sistema alla Magistratura, creando confusione nella parte che, obbligatoriamente presente in udienza, anziché assistere (dopo aver supportato il difensore con dati, elenchi, nomi, documenti, dopo aver sostenuto costi e dopo aver atteso mesi in attesa dell’agognata udienza) all’emissione dei dovuti interventi decisionali del Giudice, vedono il magistrato che, preso il suo fascicolo, lo apre e si attiva energicamente non per interrogarle e mostrare interesse alle posizioni delle parti nel merito, ma solo per vedere celermente chiusa la vertenza con un accordo, paradossalmente comportandosi, a volte anche nel corso del giudizio di secondo grado, in modo opposto a quanto il cittadino si attende dal sistema.
Ma vi è da chiedersi. E’ necessario che detta funzione, in molti casi inutile, spesso defatigante e raramente concludente, sia gestita da rappresentanti dell’organo costituzionale giudiziario, per di più composto da vincitori di concorso tecnicamente selezionati non per “mediare”, ma per compiere valutazioni di diritti, scrivere motivazioni ed amministrare la funzione autoritativa della Giustizia?
E’ intuitivo domandarsi se sia corretto e se vi sia un’opportunità sociale che un simile compito sia svolto dal costoso e farraginoso sistema giudiziario, i cui arretrati sono notoriamente biblici, ovvero se sia opportuno farlo gestire da altre figure, consentendo che ogni minuto dell’attività dei giudici sia concentrato (anche con l’intento di recuperare l’arretrato) non a convincere le parti a non fruire del loro servizio, ma a svolgere quella che è la funzione principale per cui sono stati assunti e sono pagati: istruire le cause e deciderle.
Non si nega che, in via generale, il carico dei giudizi sia eccessivo e che sia necessario introdurre ogni mezzo utile ad evitare il contenzioso, intercettando preventivamente i conflitti ed impedire l’ingolfamento degli uffici giudiziari.
Tale risultato, notoriamente, si risolve con lo snellimento della normativa, con la semplificazione delle procedure, con l’aumento degli organici e, indubbiamente, anche con la ricerca di soluzioni di composizione preventiva dei conflitti, evitandosi proprio che le questioni giungano sul tavolo del magistrato o, se e quando vi giungano, debbano dallo stesso essere considerate di ormai conclamata ed impossibile soluzione transattiva, senza che, a tal fine sia necessario alcun suo ulteriore intervento.
Sennonché i tentativi normativi finalizzati a identificare, con il dovuto pragmatismo, forme di conciliazione capaci di evitare efficacemente lo tsunami del ricorso dei cittadini alla magistratura e idonee a veder le parti comporre i conflitti in sedi preventive, non hanno dato i risultati sperati ed il contenzioso, anziché ridursi, continua a rimanere elevatissimo e, se non cresce senza controllo, è per la ingravescente e pericolosa disaffezione dei cittadini al sistema giustizia, acuita da recente aumento dei costi del sistema, difficilmente tollerabili in tempi di crisi.
Tale fallimento, per quanto riguarda le vertenze di lavoro, è stato causato, a mio avviso, da un lato, da impostazioni ideologiche delle leggi che hanno regolato le forme conciliative preventive, preoccupate di non scontentare alcune categorie, quali sindacati, Ministero del Lavoro, e gli stessi Magistrati, tutti attenti a non perdere posizioni e preoccupati di un’autentica ed efficace modifica del sistema, dall’altro della mancata identificazione di effettivi strumenti sanzionatori per le parti intenzionate a sfuggire ad una trattativa preventiva obbligatoria o con capaci strumenti premiali per le parti tali da contribuire, raggiungendo un accordo, ad evitare il conflitto giudiziale.
In tale ottica vanno quindi ricercate soluzioni nuove che stimolino le parti, prima dell’introduzione del giudizio a raggiungere un accordo, conferendo eventualmente al Giudice, successivamente chiamato a decidere, solo il compito di sanzionare, ai sensi dell’art. 96 o dell’art. 116 o 420 c.p.c, chi, nonostante le occasioni di composizione prospettate, abbia determinato, con atteggiamenti o prese di posizione illogiche o tatticamente poco accettabili, l’Ufficio a sobbarcarsi la decisione di cause manifestamente improponibili e sostenendo tesi palesemente infondate o temerarie.
La parte deve invero trovarsi di fronte ad una Magistratura che si manifesti veloce, inflessibile e fortemente sanzionante, non di fronte ad una Magistratura che sia ondivaga, complice di ritardi, indecisa, e buonista verso chi osa. La forza e l’efficacia del diritto si fonda sull’autorevolezza e sul potere sanzionatorio del decidente (è ben d’ausilio ricordare i fasci littori che accompagnavano i magistrati romani a tutela del loro imperium) non sulla capacità ed azione a mediare, ricercando compromessi che, seppur utili, sono generalmente contrastanti con il diritto.
In tale quadro di giusto “timore”, le parti devono essere indotte a non confidare più nell’adozione di atteggiamenti velleitari od ostruzionistici ed a pensare di poter farla franca, nel presupposto di un intervento mediatorio “al buio” del magistrato. Questo deve essere identificato solo come colui che, presa in carico una causa, deve manifestarsi istituzionalmente indifferente a quanto viene a muoversi per esigenze conciliative, essendo chiamato solo a condurre il giudizio e decidere, nell’unico presupposto che la funzione della Magistratura sia quella di dirimere difformi rappresentazioni dei fatti o un autentico contrasto interpretativo e mai quella di indurre le parti al compromesso.
La composizione della controversia, nello spirito di cui all’art.1965 c.c., deve quindi trovare spazio prevalentemente fuori delle aule di giustizia o in limine ad esse, non sulla cattedra del Magistrato.
E’ ben vero che molte cause (liti già sorte) si chiudono transattivamente nel corso del giudizio, ma ciò è funzionale alla gestione dei poteri dispositivi ed ai diritti delle parti, che calcolano la relativa convenienza sulla base di complesse valutazioni di rischio e di costo, tra le quali anche le tempistiche della giustizia, le incertezze del sistema ed i costi di assistenza. Tali composizioni devono avvenire per loro esclusive valutazione di convenienza e non per esigenze deflattive del contenzioso, al cui raggiungimento non può essere chiamato proprio il magistrato, il cui esperimento del tentativo di conciliazione si rivela spesso un mero adempimento ed un ulteriore elemento di allungamento del processo.
A mio avviso, i principali attori di tale compito devono essere gli avvocati, sia perché, avendo “le carte in mano” e quindi ben edotti della posizione sostanziale dei rispettivi clienti ed in grado di inquadrare giuridicamente la fattispecie sottoposta al loro patrocinio approfondito, sono in grado di identificare immediatamente, ed in modo molto più mirato del Magistrato, il “punto di caduta” dell’accordo transattivo, sia perché, avendo il dovere di orientare il cliente circa i rischi, i costi e i tempi dell’eventuale giudizio, hanno tutti i titoli per eventualmente forzare i propri clienti al raggiungimento di un accordo nel loro stesso interesse.
In tal senso devono essere riconsiderate le figure della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita, istituti che, ad oggi, non sono state ritenute applicabili alle controversie di lavoro.
Le motivazioni sottese a tale esclusione sono state identificate nella esistenza di istituti mediatori già operano nel settore e, segnatamente, le procedure di cui all’art. 31 della legge 183 del 2010, peraltro non obbligatorie, nonché nella diffidenza della rimessione ad avvocati del potere di certificare la consapevolezza dei lavoratori a compiere rinunzia a diritti considerati indisponibili.
Il progetto di legge approvato il 10.3.2017 offre, sotto tale profilo, spunti di effettiva novità, in quanto all’art. 2 a) 10, prevede che la delega al governo contenga anche norme che prevedano la possibilità, per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c., il ricorso alla negoziazione assistita.
Tale previsione, se confermata, costituirebbe una vera e propria svolta, attesa da decenni dalla avvocatura, venendo con la stessa rimossi gli obblighi, noti a tutti i colleghi giuslavoristi, connessi alla necessità, in caso di transazioni di lavoro, a ricorrere alle note sedi che garantiscono la inoppugnabilità delle rinunzie per diritti indisponibili dei lavoratori, ben potendo la verifica della effettività della volontà delle concessioni rese dal lavoratore ai sensi dell’art. 1965 c.c. essere certificate e garantite dal difensore di fiducia, che, sul punto, assumerebbe una specifica responsabilità professionale.
Il progetto di Legge sembra quindi andare nella giusta direzione attribuendo agli avvocati un ruolo che gli stessi hanno sempre rivendicato.
Va detto comunque, che tale apertura contenuta nel progetto privilegiante, come visto, all’art. 2 a) 1, la mediazione del giudice, non appare sufficiente a raggiungere concreti risultati nella composizione preventiva di vertenze di lavoro.
A mio avviso, la mediazione a mezzo legali dovrebbe essere contraddistinta da requisiti di obbligatorietà, con una proceduralizzazione formale utile alla successiva fase del giudizio.
Sostanzialmente dovrebbe prevedersi la creazione obbligata e stragiudiziale di un contraddittorio tra gli avvocati delle parti (con invito genetico, a carico di chi ricorre, alla controparte di indicare il nome di un avvocato, notificare a quest’ultimo un atto – simile alla odierna citazione – con il contenuto della rivendicazione, con allegati documenti, ctp, eventuali dichiarazioni testimoniali rese nelle forme di cui all’art. 4 della legge Legge 4 gennaio 1968, n. 15, argomentazioni in diritto e conclusioni. Ad essa seguirebbe obbligata risposta dell’altro legale, con indicazione di speculari deduzioni e conclusioni) ed una procedura preliminare pregiudiziale che, per quanto possibile, dovrebbe essere contenuta in tempi minimi accettabili.
A detta instaurazione del contraddittorio dovrebbe seguire un incontro obbligatorio tra le parti, durante il quale gli avvocati sarebbero facoltizzati a compiere repliche ed addurre nuovi strumenti probatori, redigendo infine un verbale contenente le rispettive posizioni, rese alla luce delle bilaterali argomentazioni e prove, con formalizzazione delle condizioni con le disponibilità conciliative.
In caso di accordo, dovrebbe essere prevista una serie di fattori premiali, attribuendosi ad es. alle parti sconti di natura fiscale, contributiva ed attribuendo ad es. agli avvocati dei bonus da utilizzare nell’acquisto dei contributi unificati per altre vertenze.
Anche in caso di mancato accordo, la necessaria indicazione di disponibilità conciliativa, stante la conoscenza che i legali hanno della fattispecie e dei rischi cui andrebbero incontri i clienti, farebbe emergere, in termini di alta affidabilità, e salve prese di posizione radicalmente contrastanti, il reale margine di differenza delle posizioni.
Solo a questo punto, ove gli avvocati non fossero riusciti a raggiungere un accordo, la controversia, previo versamento del contributo unificato, andrebbe sul tavolo del Giudice, il quale, trovandosi un fascicolo già istituito, con prove, consulenze e mezzi di prova già abbozzati, se non raggiunti, avrebbe meno problemi, studiando il caso, a farsi un’idea concreta della fattispecie e quindi veder fortemente ridotte le necessità istruttorie e quindi a ridurre considerevolmente i tempi della decisone.
In tale prospettiva, per i Giudici, la avvenuta chiusura transattiva di una causa non dovrebbe costituire fattore premiale, dovendosi valorizzare esclusivamente le cause decise.
Naturalmente, un comportamento passivo delle parti, il mancato colpevole riscontro alla richiesta di nomina dell’avvocato, la mancata esplicitazione della proprie difese, o l’adozione di una tattica dilatoria, attendista o non coerente con lo spirito della procedura dovrebbero essere adeguatamente sanzionati con successive decadenze istruttorie, penalizzazioni economiche, accollo dell’intero contributo processuale ecc., in modo da garantire un’efficacia alla formulata procedura preventiva.
La manifestata disponibilità transattiva non dovrebbe comunque esser mai raccolta dal giudice (in contrasto con l’attuale orientamento normativo) per ricondurre quest’ultimo ad intervenire nella transazione, da cui dovrebbe comunque manifestarsi estraneo nel corso del processo. Dovrebbe essere comunque valutata dallo stesso nel momento della decisione e solo per valutare ex post la credibilità delle posizioni assunte dalle parti e regolarsi in tema di spese, sanzioni ex art. 96 c.p.c. e con eventuale raddoppio, per la parte soccombente e dichiaratasi non disponibile, ante causam, ad un ragionevole accordo conciliativo, del contributo unificato.
Un tale sistema, ovviamente da perfezionarsi e studiarsi nella corretta procedimentalizzazione, non solo costituirebbe un modo per velocizzare il sistema giustizia, riducendo i costi e tempi delle controversie civili e del lavoro, a beneficio di tutti, ma ricollocherebbe i giudici nell’ unica ed autentica funzione di decidente, riassegnando all’avvocatura un ruolo di protagonista nella ricerca di forme di composizione delle liti.
- Tribunale di Roma – Sez. Lavoro – Dott. Lionetti – Sent. N. 638/2024 – Ricorrente L.T. difesa dall’avv. Riccardo e dall’avv. Andrea Chilosi c/ FCR - 12 Febbraio 2024
- Sblocco dei licenziamenti, ingiustizia sociale o opportunità? - 20 Aprile 2021
- Suggerimenti per la formulazione di progetti di legge utili a ridurre, snellire e razionalizzare il contenzioso civile. - 8 Gennaio 2018
- Aspetti critici sulle nuove proposte normative in tema di mediazione giudiziale nel processo del Lavoro - 22 Giugno 2017